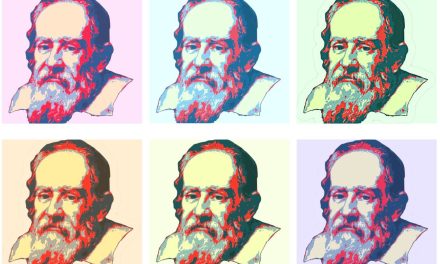Da dove nasce la scelta del nome “Le supplici” per la tua compagnia?
Il nome risale a un periodo in cui ero molto interessato allo studio della mitologia greca. Mi ha affascinato perché mi riportava a qualcosa di femminile, e in fondo, nonostante si trattasse di una tragedia, di leggero. Tuttavia, sento che questo nome fa ormai parte del passato, per cui nel futuro più prossimo c’è l’idea di cambiarlo, anche in ragione delle trasformazioni che ci sono state negli ultimi anni all’interno del gruppo. Si è aperta una nuova storia, anche nelle pratiche più quotidiane di lavoro. Ad esempio, prima lavoravamo di più in sala, sperimentando senza la finalità di creare un prodotto pronto per essere visto, anche a costo di non ottenere l’approvazione del pubblico; con il passare degli anni invece, il frutto delle nostre sperimentazioni si è tradotto in una poetica personale, tesa ad un pubblico ben preciso. Questa prima modalità di ricerca mi ha permesso di indagare quella che io chiamo “natura folle”, un’urgenza personale che ciascun artista tenta di portare in scena. La natura folle è la profonda indole creativa di un artista e, perché possa essere scoperta, è necessaria una fase di sperimentazione completamente libera, cui segue, con il tempo, l’elaborazione di una poetica personale molto riconoscibile.
La ricerca di un’urgenza personale, di una propria “natura folle”, in che modo interagisce nel rapporto tra allievo e maestro?
Sempre da parte dei maestri c’è il desiderio di coltivare nei giovani un pensiero libero; d’altro canto per l’allievo c’è sempre il rischio di ricalcare le orme di chi ti ha preceduto. Io ho lavorato dieci anni con Virgilio Sieni e credo che lui sia stato un vero maestro, proprio perché mi ha insegnato a non essere lui. Questa è la sfida più difficile per un insegnante, e per questo credo sia importante per i giovani avere la possibilità di scoprire quale sia la loro “natura folle”. È da questo materiale che nasce la poetica di un artista, che all’inizio può non essere comunicativa, ma che con il tempo consente di dare una direzione al proprio lavoro per rendersi riconoscibili e crearsi un pubblico di riferimento.
Qual è il processo creativo che ti guida nella composizione della coreografia? Che ruolo ha l’improvvisazione in sala prove e quanto di quello che vediamo sul palco è frutto di un’improvvisazione?
Normalmente quando arrivo in sala ho già chiaro il disegno che cercherò di realizzare: quali sensazioni e quali impressioni vorrò trovare nel lavoro. Per questa ragione porto con me dei materiali da mostrare ai danzatori per instaurare con loro un dialogo: io mostro qualcosa che loro dovranno continuare. In questa fase gioca un ruolo chiave l’improvvisazione. Un esercizio che faccio fare molto spesso è quello di immaginare di essere in un ambiente inusuale e di incontrare delle forme di vita aliene, sconosciute; ai danzatori spetta il compito di relazionarsi con questi esseri sconosciuti, vegetali e animali, creando un dialogo anche senza avere gli strumenti adeguati. È in questo tentativo che iniziano a trovare dei movimenti poco usuali, di cui io prendo nota, quasi come un geologo. A volte è proprio grazie alle suggestioni che mi arrivano da loro che aggiungo delle scene e modifico il mio lavoro. Questo è il mio attuale modo di comporre.
Che ruolo gioca il pubblico nella creazione dei tuoi lavori? Quanto è importante lo sfondo immaginativo dello spettatore nel momento della fruizione?
Sempre più negli ultimi anni mi metto nei panni dello spettatore. Credo che le persone vadano a teatro non solo per vedere qualcosa, ma per entrare in un dialogo immaginativo con ciò che stanno vedendo. Io non spiego quello che porto in scena e allo stesso modo il danzatore non danza perché vuole spiegare qualcosa, ma perché ama danzare. Questo si traduce certamente in un dialogo che potremmo definire ibrido, perché basato su un linguaggio che avvicina senza spiegare. Ecco allora che il mondo che creo sulla scena è fatto di luci che sembrano galassie, di aurore boreali, di ghiacciai islandesi oppure di forme che non si possono decifrare, ma di cui lo spettatore sente di fare parte. È proprio questa conversazione, muta ma possibile, con il mondo organico e inorganico, che cerco di restituire sulla scena. Per questa ragione l’uomo, per come lo conosciamo nella sua quotidianità, non fa parte dei paesaggi che cerco. Io non lavoro su stati emozionali, non lavoro sull’attualità — in questo senso mi sento “figlio” degli americani, in particolare Merce Cunningham, José Limon e Trisha Brown: il mondo a cui ho aderito è quello di una danza che non ci racconta delle storie, ma è semplicemente qualcosa che viene messa in atto, senza interpretare né spiegare.
Agnese Di Girolamo e Allegra D’Imporzano
Photo © First Rose
Questo contenuto è parte dell’osservatorio critico MILANoLTREview